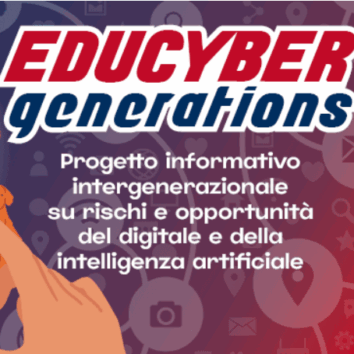Lunedì scorso mi trovavo a Lisbona quando il video sulla storia della chiesa gotica do Carmo – a causa del devastante terremoto del 1755 ne rimane solo lo scheletro di archi e colonne, che crea una comunicazione diretta con il cielo come a San Galgano vicino Siena o allo Spasimo a Palermo – si è bruscamente interrotto: la luce era andata via. Si trattava del black-out che ha oscurato l’intera penisola iberica lunedì scorso. Fuori i caratteristici tram cittadini si erano paralizzati, aggrappati ai sali-scendi tipici di Lisbona come scalatori in preda a una crisi. Tutto si era spento. I cellulari non prendevano e si affannavano nella vana ricerca della rete oscurata dai frenetici tentativi della folla smarrita a caccia di informazioni. Semafori spenti, voli cancellati, surgelati in pericolo. Impossibile tornare in Italia. Non si poteva avere una camera d’albergo senza contanti, che però non era possibile prelevare da banche e bancomat fuori uso. Pompe di benzina mute, macchine sempre più in riserva. Siamo così abituati ad affidarci alla tecnologia che, solo quando viene meno, ci ricordiamo che la vita è fatta delle materie prime che l’alimentano e della materia prima che ci alimenta (i rapporti umani: informazioni per trovare una strada, un letto su cui dormire, notizie sul proprio volo…). L’ansia cresceva al passare delle ore: chi siamo noi senza informatica?
Il controllo della realtà è fondamentale per la vita, e lo abbiamo affidato all’informatica. Qualche anno fa usavamo telefoni fissi e conoscevamo i numeri a memoria, giravamo i vinili, ci riempivamo di contanti, scattavamo le nostre 24 foto e avevamo Tuttocittà in macchina… Ora abbiamo affidato il controllo ai bit che ci hanno semplificato la vita, però quando si fermano, fermano anche noi. Mi è tornato in mente proprio il libro di un Nobel portoghese, un romanzo del 1995 tanto claustrofobico quanto potente: Cecità di José Saramago. Questa la storia: in una città senza nome si diffonde una misteriosa epidemia di «cecità bianca» che rende incapaci di vedere altro che una luce lattiginosa. Tra i contagiati ci sono un oculista e sua moglie, la quale inspiegabilmente indenne rimane accanto al marito. Testimone di orrori indicibili dettati dalla lotta per sopravvivere, cerca di mantenere un barlume di umanità prendendosi cura delle persone vicine, per affrontare insieme fame, violenza e disperazione. Un romanzo allegorico in cui questo «white-out» svela la fragilità di una civiltà illusa che il progresso materiale coincida con quello morale e sociale: «Perché siamo diventati ciechi? Non lo so, forse un giorno si arriverà a conoscerne la ragione. Vuoi che ti dica cosa penso. Parla. Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo. Ciechi che vedono. Ciechi che, pur vedendo, non vedono». Anche noi andavamo avanti un po’ alla cieca. Quando ci siamo avvicinati all’aeroporto per capire la situazione «dal vivo» abbiamo visto centinaia di persone per terra, alcune in carrozzina da ore, code infinite a bagni impraticabili… Eppure tutti si parlavano, si aiutavano, si tiravano su di morale: non solo il morale, ma la morale, l’etica. Mi sono allora tornate in mente parole che spiegano la nostra «cecità bianca»: «Un progresso addizionabile è possibile solo in campo materiale. Qui, nella conoscenza crescente delle strutture della materia e in corrispondenza alle invenzioni sempre più avanzate, si dà chiaramente una continuità del progresso verso una padronanza sempre più grande della natura. Nell’ambito invece della consapevolezza etica e della decisione morale non c’è una simile possibilità di addizione per il semplice motivo che la libertà dell’uomo è sempre nuova e deve sempre nuovamente prendere le sue decisioni. Non sono mai semplicemente già prese per noi da altri – in tal caso, infatti, non saremmo più liberi. La libertà presuppone che nelle decisioni fondamentali ogni uomo, ogni generazione sia un nuovo inizio… Il tesoro morale dell’umanità non è presente come sono presenti gli strumenti che si usano; esso esiste come invito alla libertà e come possibilità per essa», lo scriveva Benedetto XVI nella sua enciclica sulla speranza. La libertà non si può dare mai per acquisita, ma sempre da iniziare, e ogni forma di «interruzione» (blackout, guerra, pandemia, crisi…) rivela se siamo veramente liberi noi che ci crediamo evoluti semplicemente perché progrediti. «Il benessere morale del mondo – continua il testo – non può mai essere garantito semplicemente mediante strutture, per quanto valide esse siano. Tali strutture sono necessarie, tuttavia non possono e non devono mettere fuori gioco la libertà dell’uomo. Anche le strutture migliori funzionano soltanto se in una comunità sono vive delle convinzioni che siano in grado di motivare gli uomini a una libera adesione all’ordinamento comunitario. La libertà necessita di una convinzione; una convinzione non esiste da sé, ma deve essere sempre di nuovo riconquistata comunitariamente. Poiché l’uomo rimane sempre libero e poiché la sua libertà è sempre anche fragile, non esisterà mai in questo mondo il regno del bene definitivamente consolidato. Chi promette il mondo migliore che durerebbe irrevocabilmente per sempre, fa una promessa falsa; egli ignora la libertà umana… Se ci fossero strutture che fissassero in modo irrevocabile una determinata – buona – condizione del mondo, sarebbe negata la libertà dell’uomo, e per questo motivo non sarebbero, in definitiva, per nulla strutture buone». Un Dio che non costringe al bene – senza libertà non può esserci amore – o è pazzo o è Amore, o entrambi. Noi che invece vogliamo il controllo di cose e persone, tendiamo a liberarci del peso della libertà e delle scelte, per questo le affidiamo alle macchine, ora più che mai con l’IA. Ma la libertà, e quindi un progresso morale, si dà sempre solo quando possiamo scegliere e non quando siamo dispensati dal farlo. Le élite impongono scelte che la maggioranza spesso non vuole o non comprende, e così populismo o disinteresse sono la reazione di molti adulti all’estromissione dalla partecipazione, ansia o indifferenza quella delle nuove generazioni escluse dalla storia prima ancora di esserci entrate. L’uomo sociale o politico, che partecipa comunitariamente alla vita, è stato esiliato da quello tecnologico ed economico, ma il progresso in avanti (materiale) non è reale se non è anche progresso in alto (spirituale). E se nel 1946 Quasimodo scriveva «Sei ancora quello della pietra e della fionda,/ uomo del mio tempo», oggi come stiamo? Nelle 48 ore in più trascorse a Lisbona in attesa di un nuovo volo abbiamo incontrato un tassista che quando abbiamo cominciato a parlargli in inglese ha detto: «Perché parlare la lingua di Shakespeare se potete parlare quella di Michelangelo?». Un tempo aveva un’azienda che lo aveva portato alcuni anni in Italia. La sua voce gioiosa garantiva verità alla sua storia: «L’azienda è fallita, sono andato un anno in Brasile, dove ho aperto con mia moglie un caffè sotto le palme che andava bene, ma poi la nostalgia degli amici ci ha riportato qua, e ora faccio il tassista». In Portogallo la chiamano «saudade», sentimento che Tabucchi definiva in modo geniale «nostalgia del momento che state vivendo in questo momento» (Viaggi e altri viaggi), l’intuizione che ogni tanto abbiamo del paradiso in terra, accompagnato dalle cosiddette lacrime di gioia, collirio per quando diventiamo ciechi alla vita. Il progresso umano è dove e quando c’è questa bellezza fatta di legami, cura, amore e non in un impossibile smisurato accumulo, che ci rende più nevrotici, malati, insicuri, dipendenti, violenti: in white-out (somma di black-out e burn-out). La libertà è scegliere ogni giorno di aprire gli occhi sul qui e ora, per tornare a vedere il mondo e la sua carne, per gioirne e prendercene cura, come risponde la moglie vedente al marito cieco nel romanzo di Saramago: «“Non ti posso obbligare”. “Infatti no, amore mio, non puoi, resto per aiutare te, e gli altri che verranno”».
Fonte: Alessandro D’Avenia | Corriere.it