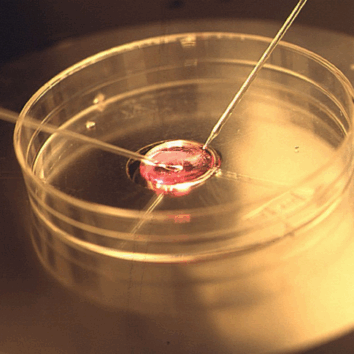La parola (lógos) è la marca distintiva dell’uomo che consente l’incontro con l’altro (diá- logos) e la convivenza nella città (pólis). È causa di consolazione e afflizione, di pace e di guerra, di salvezza e di morte, perché può «unire» (syn-bállein) o «dividere» (dia- bállein). Nell’era della comunicazione semplificata e aggressiva, la parola rischia di perdere il suo significato originario e il suo volto autentico, e di essere ridotta a vocabolo, puro suono anonimo e inanimato. Abbiamo bisogno di un’ecologia linguistica che ci consenta di parlare bene e di trovare le parole giuste per nominare questo nostro presente.
Alla parola la retorica classica, l’ars dicendi, affidava il triplice compito di «insegnare» (docere), «affascinare» (delectare), «convincere» (movere o flectere). Per raggiungere tali scopi gli autori antichi plasmeranno la lingua fino a diventarne tiranni. Così Lucrezio crea verba nova, parole nuove, sconosciute prima di lui, al fine di propagandare le res novae, un messaggio nuovo e mai udito: rivoluzionarie le idee, rivoluzionarie le parole. Orazio, dal canto suo, rende nuove (nova) le parole note (nota) tramite la callida iunctura, il nesso originale, accorto, diremmo smart. Seneca, percorre una strada ancora diversa. Per supplire, al pari di Lucrezio, alla povertà (paupertas), anzi all’indigenza (egestas) della lingua latina rispetto alla lingua greca, egli attribuisce alle parole d’uso quotidiano e dei linguaggi tecnici un significato nuovo rispetto a quello abituale, operando il passaggio dall’ambito concreto a quello astratto, da quello esteriore a quello interiore. Siamo nel I secolo d.C.: era il tempo degli imperatori tiranni Caligola, Claudio, Nerone, quando ormai l’ultima trincea della libertà era quella dell’interiorità. Con Seneca e l’Impero, dissolta la complessa struttura repubblicana, anche la lingua si semplificherà: alla subordinazione del periodo subentrerà la coordinazione della sententia, la frase breve e staccata. La parabola della prosa letteraria latina si compirà con l’affermazione della singola parola in età postclassica, finché i Cristiani, «portatori di una spiritualità nuova, ne restaureranno l’architettura». A conferma che le leggi della lingua, anche se non in modo meccanico e isomorfico, sono correlate all’organizzazione sociale, al clima politico e, soprattutto, al mutamento delle visioni del mondo.
Dai classici apprendiamo che la parola è di duplice segno. Se simbolica (syn-bál-lein), unisce, consola, salva; se diabolica (dia-bállein), divide, affanna, uccide. Ne era consapevole un Cicerone appena ventenne, il quale alla domanda «se sia maggiore il bene o il male che la parola ha fatto alla politica» (L’invenzione retorica 1, 1) risponde che il ruolo della parola è positivo, addirittura salvifico per la costruzione della città e la redazione delle costituzioni, quando essa è proprietà degli eloquentes, «coloro che parlano bene», perché schierano l’eloquentia a fianco della sapientia. Ma, consapevole del duplice taglio della parola, Cicerone aggiunge che il suo uso è negativo, anzi nefasto, quando essa è proprietà dei disertissimi homines, «i più abili comunicatori», i demagoghi: «In effetti, quando vedo la crisi della nostra repubblica, quando con la mente faccio la rassegna delle disgrazie che in passato hanno colpito le nazioni più importanti, constato che non piccola è la parte di rovina procurata dagli uomini più bravi a usare le parole». A giudizio di Cicerone, è nel segno di questa duplicità che la parola scandirà tutta la storia della repubblica. L’eloquenza romana infatti, come egli ci ricorderà qualche decennio più tardi nel Bruto, conoscerà la sua parabola dallo splendore dell’alba, quando si affermavano i boni oratores provvisti di eloquentia e sapientia, alla miseria della notte della repubblica, quando prevarranno gli agitatori popolari. Egli stesso confesserà amaramente di aver conosciuto «molti abili parlatori, ma nessun vero oratore» (L’oratore 18 disertos… multos, eloquentem… neminem). Già nel V se- colo a.C. Gorgia, principe dei sofisti e maestro di incantamenti verbali, aveva teorizzato (Elogio di Elena 13) che tutta la vita, privata e pubblica, è una «battaglia di parole» (hámilla lógon), una lotta tra «discorsi duplici» (dissói lógoi), come vero / falso, giusto / ingiusto, buono / cattivo, bello / turpe.
Che ne è oggi della parola? Viviamo in un’epoca di paradossi: a fronte del maxi- mum dei mezzi di comunicazione sperimentiamo il minimum di comprensione; e a fronte della moltiplicazione dei problemi economici, sociali e morali operiamo una riduzione e un impoverimento delle parole. Una delle cause principali della volgarità attuale è l’incuria delle parole, e parlare scorrettamente, diceva Platone, oltre a essere una cosa brutta in sé «fa male anche all’anima» (Fedone 115 e).
Sì, perché, come diceva Basilio (Epistola 9, 1), la parola è icona dell’anima. Scontiamo un duplice errore: da un lato consideriamo la parola strumento di comunicazione, dimenticando che la parola è originaria e precede la comunicazione, la quale è mediazione (per questo parliamo di medium e di media); dall’altro la riduciamo a vocabolo, vale a dire puro suono deprivato del proprio significato. Già Frontone, un retore del II secolo d.C., mentre invitava a usare le parole migliori (optima) e cariche di significato (significantia), metteva in guardia dall’usare i verba obvia, «parole che sono sulla via», che tutti usano e usurano, dimenticandone il valore originario. Anomalia, questa, già denunciata dal Catone di Sallustio: «Abbiamo smarrito il vero significato delle parole» (Catilina 52 vera vocabula rerum amisimus). Così le nostre parole, anziché illuminare e svelare, occultano la cosa e sequestrano la realtà. A questo proposito, l’elenco dei nostri crimini si allunga di giorno in giorno: abbiamo ridotto la dignità a un «decreto», la politica a un «contratto», la pace a «condono fiscale». Ancora: il maestro è scaduto a «influencer», il discepolo a «follower», lo statista a «leader», il rifugiato a «clandestino», il volto a «faccia». Parole ormai mute, disossate, cadaveriche. Abbiamo bisogno di un’ecologia linguistica. Già Tucidide, alla vigilia della guerra del Peloponneso, individuava nell’uso ingannevole della parola il sovvertimento della vita civile: «Pretesero persino di cambiare la consueta accezione delle parole in rapporto ai fatti, sulla base di ciò che ritenevano giustificato. La temerarietà sconsiderata fu ritenuta coraggiosa solidarietà di partito; la prudente cautela, speciosa vigliaccheria; l’equilibrio, ammantata codardìa; l’assennatezza in tutto, inerzia verso tutto; l’impetuosa impulsività fu accreditata a un temperamento virile; il riflettere con calma, in nome della sicurezza, a suadente, pretestuosa riluttanza» (La guerra del Peloponneso 3, 82, 4).
Per avere piena coscienza della parola, dobbiamo recuperare il suo valore etimologico, vale a dire originario, profondo e vitale che abbiamo smarrito. L’etimologia ci ricorda che competere vuol dire «andare (petere) insieme (cum) nella stessa direzione», e non farsi la guerra; comunicare, «condividere (cum) una funzione o un dono (munus)», e non occuparsi delle notizie negative o dei retroscena; Occidente è «il mondo che tramonta (occidere)» in opposizione a Oriente, «il mondo che sorge (oriri)»; maestro è «colui che ha un ruolo superiore (magis) in relazione (ter) agli altri», in opposizione a ministro, «colui che ha un ruolo inferiore (minus) in relazione (ter) agli altri»; scuola (da scholé) è «il tempo irrinunciabilmente riservato alla propria formazione e crescita culturale e politica». Gioverà sapere che l’«intelligenza» comporta «cogliere (legere) il dentro (intus) e la relazione (inter) delle cose»; che il nome «uomo» rimanda non al cielo ma alla terra (humus); che in questo bivio senza segnaletica dei nostri giorni stiamo scontando tutta la complessità e drammaticità della parola finis: «la fine» da patire, «il fine» da raggiungere, «il confine» da oltrepassare.
In compagnia dell’etimologia sarà più facile capirci, più difficile mentire.
Ma il compito primario e fondamentale è prendere coscienza che la parola è il segno distintivo dell’uomo. Anzi, che noi siamo parola. «Chiamo uomo chi è padrone della sua lingua». In questa sentenza fulminante di don Milani (Lettera a Ettore Bernabei, 1956), ispirata a un deciso afflato di giustizia sociale, trovo il più bel commento al passo in cui Aristotele (Politica 1253 a) riconosce nella parola (lógos) la marca che caratterizza l’uomo e lo distingue dagli animali, che ne sono privi (tà zôa áloga). La parola: il bene più prezioso, la qualità più nobile, il sigillo più intimo. A una persona, a un gruppo, a un popolo puoi togliere averi, lavoro, affetti: ma non la parola. Un divario economico si ripiana, un’occupazione si rimedia, una ferita affettiva si rimargina, ma la mancanza o l’uso ridotto della parola negano l’identità, escludono dalla comunità, confinano alla solitudine e quindi riducono allo stato animale. «La parola – continuava il profetico prete di Barbiana – è la chiave fatata che apre ogni porta». È l’antenna che capta ogni dimensione: «Vola alta, parola, cresci in profondità, / tocca nadir e zenith della tua significazione» (Mario Luzi).
La parola tutto può, come già insegnava la saggezza classica. È un potente sovrano, nonostante il suo corpo esilissimo. Essa può «spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione»; persino riscattare Elena, la donna più screditata dell’antichità (Gorgia, Elogio di Elena 8). Come dirà Lucrezio, essa può vincere mostri ben più pericolosi di quelli del mito affrontati da Ercole: i mostri interiori della cupidigia (cupido) e della paura (timor). Sono mostri che si sconfiggono con parole di verità (dicta veridica). Immenso il suo potere. Ce lo ricorda uno scrittore del nostro tempo (Elias Canetti), Nobel per la letteratura nel 1981: «Se io fossi davvero uno scrittore, dovrei essere capace di impedire la guerra… Alla situazione che ha poi reso la guerra davvero inevitabile si è arrivati per mezzo di parole, parole su parole usate a sproposito. Se così grande è il potere delle parole, perché esse non dovrebbero anche essere in grado di impedire la guerra?»
Quando comunichiamo, la nostra parola (lógos) attraversa l’altro, creando il diá-logos (diá, «attraverso»). Dialogo è parola impegnativa che, anziché richiamare accomodamento, compromesso o acquiescenza, rinvia allo scambio, al confronto e allo scontro di parole e idee tra gli uomini, chiamati o condannati a vivere in società, perché aggiungeva Aristotele l’altra marca distintiva dell’uomo è la sua vita nella pólis, per cui chi vive separato dalla comunità è «o bestia o dio (e theríon e theós)». Il dialogo è stata la grande novità di Socrate, il quale dalla narrazione e formularità omerica, incentrata sulla passività dell’ascolto, proietta nella dinamicità del dibattito, della discussione, del ragionamento. Ogni affermazione va spiegata e motivata: nulla deve essere dato per scontato. Il passaggio dal monologo al dialogo, dal racconto al discorso strutturato su domanda e risposta implica il passaggio dalla paratassi alla ipotassi, dalla coordinazione alla subordinazione. Socrate tramite il dialogo mirava al superamento del «discorso privato», l’ídios lógos caro ai Sofisti, per approdare a quel «discorso comune», il koinós lógos, che ci consente di convivere nella polis. L’esperienza del dialogo ci segna e ci arricchisce anche come singoli, secondo quanto ha detto Dan Zadra: «Se due persone si scambiano un dollaro, restano sempre con un dollaro ciascuno: se invece si scambiano un’idea, entrambi ne hanno due». Solo col dialogo e nel dialogo possiamo convivere e progredire. Negli Atti degli Apostoli (2, 1-11) leggiamo che il giorno di Pentecoste è accaduto un miracolo «traduttivo», per cui tutti, Giudei e Gentili, si capivano gli uni gli altri, parlando ognuno la propria lingua. Noi oggi abbiamo bisogno di una sorta di Pentecoste laica, che ci consenta di capirci restando ciascuno fedele alla propria lingua, analogamente a quanto avvenuto nel giorno natale della Chiesa. Seguendo l’unica via possibile: incrociare e attraversare il lógos, la parola e la ragione dell’altro. Il dialogo come nostra destinazione e come nostro destino.
L’alternativa alla Pentecoste è Babele (Genesi 11, 1-9): il miraggio e l’ossessione di avere una sola lingua dominatrice e imperialistica, «un solo labbro», da parte degli appartenenti a un popolo che Dio punisce confondendo e disperdendo perché non si capiscano più. Sarà proprio la Pentecoste, l’anti-Babele, a far sì che le varie genti tornino a capirsi.
Lógos è la parola della parola, che ha soppiantato gli altri sinonimi (a partire da épos e mythos); la parola simbolo del mondo greco (ben 14.000 occorrenze nella sola letteratura greca del V-IV secolo a.C. giunta a noi); la parola diffratta in significati plurimi (da «raccolta, elenco, calcolo» a «narrazione, discorso», fino a «misura, proporzione»). I due testi archetipici della parola sono Eraclito e la Bibbia. Potremmo dire, il lógos orizzontale e il lógos verticale.
Per Eraclito (VI-V secolo a.C.) il lógos è realtà eterna (fr. 1 Diels-Kranz) che tutto e tutti tiene uniti (fr. 2 Diels-Kranz), benché i più vivano come se fossero dotati di un «pensiero individuale» (idía phrónesis), senza riconoscersi nel pensiero comune (koinós lógos). Se ascoltiamo la voce del lógos, comprendiamo che «tutto è uno» (fr. 50 Diels-Kranz) e tutto si sviluppa e si moltiplica nell’anima di ognuno (fr. 115 Diels-Kranz), anche se natura e percorso ne sono insondabili: «Per quanto tu possa camminare, i confini dell’anima non li troverai, anche se percorressi ogni strada: così profondo è il suo lógos» (fr. 45 Diels-Kranz). Per Eraclito, dunque, il lógos è la ragione universale che governa il tutto; è la ragione umana che comprende la ragione universale e che indica all’uomo la via della vera sapienza; è, infine, la parola, il discorso che esprime questa conoscenza.
Il lógos cosmico e il lógos interiore annunciano e testimoniano che la realtà diviene in continuazione, la proporzione governa gli incessanti cambiamenti, l’armonia rappresenta l’unità degli opposti in una loro eterna alternanza e compresenza (fr. 10 Diels-Kranz «Interezze non intere, convergente divergente, consonante dis- sonante, e da tutte le cose uno e da uno tutte le cose»).
Per la Rivelazione ebraico-cristiana la parola sta all’inizio sia della creazione sia della incarnazione: «In principio… Dio disse: “sia la luce”. La luce fu», sta scritto nella Genesi (1, 1-3); «In principio era la Parola», leggiamo nel Vangelo di Giovanni (1, 1). Nell’Antico Testamento all’origine del mondo non era né «una lotta teogonica, una teomachia, come insegnava la mitologia babilonese»3 né il Caos come voleva quella greca (Esiodo, Teogonia 116 «All’inizio era il Caos», prótista Cháos géneto), ma era la Parola di Dio: la quale ordina il mondo (Genesi 1, 1) e crea i cieli (Salmo 33, 6 ss.; cfr. Salmo 19, 2-5), fa guarire e fa perire (Salmi 107, 20; 147, 18; Sapienza 18, 14-15), resuscita i morti (Ezechiele 37, 11-14), frantuma come un martello le pietre (Geremia 23, 29), è stabile come il cielo (Salmo 119, 89), si moltiplica nel mistero (Salmo 62, 12 «Una parola ha detto Dio, due ne ho udite»), va mangiata dal profeta insieme con il rotolo in cui è scritta (Eze- chiele 2, 19), è «voce di sottile silenzio» (Primo Libro dei Re 19, 13). Rispetto all’Antico, il Nuovo Testamento presenta due novità: in primo luogo la parola di Cristo sostituisce la legge invalidando la Torah: «Avete udito quello che fu detto agli antichi, io invece vi dico» (Matteo 5, 21 ss.); alla legge data attraverso Mosè subentrano la grazia e la verità date attraverso Cristo (Giovanni 1, 17). In secondo luogo, mentre nell’Antico Testamento la Parola di Dio crea e opera, nel Prologo di Giovanni la Parola di Dio si fa persona ed evento. Non più il lógos di Dio (lógos tou theoû) o il lógos divino (lógos theîos), ma la Parola, il Lógos assoluto, senza specificazioni e senza attributi: et Verbum caro factum est (kai ho lógos sarx egé- neto, Giovanni 1, 14). Cristo è la Parola che si fa carne, uomo, storia. Qui la ver- ticalità raggiunge il suo compimento.
Il nostro è il tempo non dei cittadini, ma dei padroni del linguaggio. Nel tempo della retorica totale, del rinnovato impero della retorica – dove la parola sembra più che mai essere il destino di ognuno di noi e dove i colpi di Stato si fanno a suon di parole prima ancora che di armi – la vera tragedia è che i padroni del linguaggio mandino in esilio i cittadini della parola. In questa prospettiva la filologia, «la cura amorevole della parola», trascende il significato di disciplina specialistica e di mestiere umbratile di pochissimi studiosi, e si eleva a impegno severo e nobile di ogni uomo che non intenda né censurare né censurarsi.
Siamo tutti filologi, perché a fronte dei grandi cambiamenti in atto dobbiamo trovare parole adeguate per nominare questo presente così globale eppure così frantumato, così estraneo eppure così invadente. Lo abbiamo visto al- l’inizio di questa nostra riflessione. Il poeta Lucrezio, l’apostolo della ragione, alla fine del I secolo a.C., nel poema La natura delle cose confessava di creare, durante la veglia delle notti stellate, quelle parole nuove (verba nova) che gli schiudessero nuovi cieli e nuove terre, che gli consentissero di diffondere nella tradizionalista e ormai collassata Roma repubblicana le sue nuove idee, la sua «rivoluzione» (res novae). Anche per noi s’impone la veglia per i verba nova. Ma noi abbiamo res novaes da proporre?
Fonte: Ivano Dionigi | FrancescoMacrìblog.com