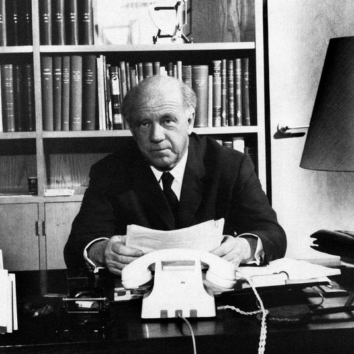Tahiti, 1897. Un uomo dipinge senza posa da un mese su un’immensa tela grezza, fatta di sacchi cuciti: è il suo testamento, poi si ammazzerà. Paul Gauguin, fuggito da una Francia falsamente viva, lascia la famiglia e va nel cuore del Pacifico, ma neanche in Polinesia trova il paradiso e l’innocenza in cui sperava. Cambia cielo non anima chi corre per mare: al suo inferno interiore si aggiunge la notizia della morte della figlia Aline, di 8 anni. Così prova a sconfiggere la tenebra con i colori e, come un condannato a morte, dipinge il suo ultimo desiderio, che intitola «Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?»: «Ai due angoli in alto, dipinti in giallo cromo, c’è il titolo a sinistra e la mia firma a destra, come un affresco, guasto agli angoli, applicato su un fondo oro». Era la fine e il fine della sua ricerca artistica ed esistenziale: «Ho trasmesso in questo quadro tutta la mia energia, una così dolorosa passione in circostanze così tremende che la vita ne sgorga fuori direttamente». Il dipinto ruota attorno a una donna che coglie un frutto, ma attorno a lei è rappresentato il tragico evolversi delle stagioni della vita verso la morte: la vita è una grande promessa non mantenuta. Il grandioso quadro non basta a ritrovare la speranza e Paul ingerisce il veleno, ma in quantità tale da vomitare, scampando alla morte che lo coglierà qualche anno dopo, per sifilide. Anche il suo amico Vincent Van Gogh aveva perso la speranza e, sette anni prima, mentre dipingeva nei campi di Auvers-sur-Oise, si era sparato un colpo di pistola. Due anime inquiete e parallele, alla ricerca di una irraggiungibile vita autentica.
Nel quadro di Paul la natura polinesiana resta uno scenario fantastico e l’oro, che esce dai finti angoli, è quello del fondo delle icone: un oltre eterno, ma qui celato e irraggiungibile. Quell’oro ha la stessa origine del giallo dei campi di grano ai quali Van Gogh dedicò i suoi ultimi sforzi: «Ho dipinto tre grandi tele: immense distese di grano sotto cieli tormentati e non ho avuto difficoltà a esprimere la mia tristezza e solitudine», come minaccia il nero volo dei corvi su quei campi. Entrambi cercarono il paradiso, ma non saltò fuori: il cielo restava chiuso e la felicità impossibile. Più costruiamo il paradiso con le nostre forze, più rimaniamo delusi. Quando nella storia l’uomo ha cercato di realizzare il paradiso in terra non ha prodotto che danni, dittature e stermini. La terra non chiede paradisi ma contadini la cui la libertà è l’aratro con cui aprire solchi o ferite nel «campo umano», che può diventare giardino o groviglio, raccolto o carestia, sta a noi scegliere. Come?
Affido la risposta a una donna che amo: Caterina da Siena. A 31 anni dettò un capolavoro intitolato Dialogo della divina provvidenza (1378), un colloquio intimo con Dio Padre, in un passo del quale, la futura patrona d’Italia, lamentandosi con Lui perché uomini e donne (a partire da lei) sono così imperfetti e fragili, riceve questa risposta: «Ho elargito molti doni e beni, sia spirituali che corporali – dico corporali con riferimento a ciò che è necessario per la vita dell’uomo – distribuendoli tutti in modo così differente che a nessuno toccassero tutti, affinché voi uomini aveste necessariamente occasione di reciproco aiuto. Certo, avrei potuto dotare ogni uomo di tutto ciò che gli fosse necessario, sia per l’anima sia per il corpo, ma Io volli che gli uni avessero bisogno degli altri, e si facessero miei ministri col distribuire agli altri quelle grazie e quei doni che hanno ricevuto da me. Lo voglia o meno, l’uomo non può fare a meno di fare atti d’amore. Ciò mostra come nella mia casa via siano molti compiti attraverso i quali Io non mi aspetto altro che amore».
Trovo queste righe illuminanti per chiunque, credenti o meno. La terra non è un paradiso perduto o mancato, ma una casa in costruzione, in cui ciascuno ha un compito, di cui doni e limiti personali sono le istruzioni. La divina provvidenza non è in un Dio tappabuchi a cui il mondo è venuto male, ma siamo noi stessi, ricchi di doni e di limiti: sono io che decido se mettere al servizio degli altri i doni che ho, o farmi i fatti miei; sono io che decido di chiedere aiuto a chi ha doni che io non ho, senza vergognarmi dei miei limiti. Le relazioni sono generative quando decidiamo di prenderci la responsabilità del destino delle cose e delle persone. A volte qualcuno riesce a dare solo il suo dolore e la sua fragilità, ma anche questi sono doni che invitano a offrire cura. La storia così diventa uno scenario fatto per dare e ricevere, ciascuno nel suo ambito e come può. Per esempio nel mio questo significa mettere al primo posto alunni e colleghi, e scoprire che cosa ciascuno ha di unico da dare e che cosa invece ha bisogno di ricevere. Se non lo si fa le relazioni diventano degenerative, che non vuol dire faticose o difficili (è normale nelle relazioni vere) ma prive di vita, cioè le energie e la gioia si spengono, e arrivano nell’ordine: solitudine, stanchezza, disperazione e distruzione. Tutto sta a noi, ancora una volta.
Negli stessi anni in cui Van Gogh e Gauguin trasformavano la loro sete di paradiso in arte, disperazione e fuga, Paul Cézanne ne faceva un accanito amore per la terra, nella sua Aix-an-Provence. Egli rivoluzionò l’arte dipingendo, fino alla morte che lo colse en plain air, lo stesso soggetto, le amate montagne di Sainte Victoire: «Potrei trascorrere dei mesi a lavorare sempre nel medesimo luogo, limitandomi a spostarmi di pochi centimetri a destra o a sinistra». Amo questa accettazione del presente, quest’attenzione tenace alla terra: «si possono trarre tesori da questo paesaggio, che non ha ancora trovato un interprete capace di rappresentare il profluvio di ricchezze che esso riserva». Il lavoro diventa scoperta di sé e del mondo: «ho bisogno di conoscere la geologia, come il massiccio di Sainte Victoire si radica, tutto ciò mi commuove e mi rende migliore». Cézanne posa in ogni tela la mano sulla terra, come se fosse il primo uomo. Questo «tatto» della prima volta, quello di chi apre con cura un regalo appena ricevuto, in tempi «senza tatto» o di «contatto» superficiale, è più che mai necessario: permette di liberare l’eden che c’è già, anche se timidamente nascosto, nel quotidiano, per custodirlo e coltivarlo con il proprio impegno. Cézanne dipingeva il suo amore per ogni mela e lo affidava, per sempre, alla mela dipinta. Anche noi, se «a capo» di ogni cosa che facciamo poniamo questo amore paziente per cose e persone, trasformeremo il lavoro in «capo-lavoro»: vita e gioia, in noi e attorno a noi.
Questo voglio augurarvi nell’ultimo «letto» prima della pausa estiva: un nuovo amore per la terra – cose e persone – che ci è data, perché solo così porteremo a maturazione noi stessi, quelle cose e quelle persone. Questo è ciò che chiedo e ricevo da Dio ogni giorno: un amore che non si stanchi della ripetizione dei giorni e dei volti, ma si rinnovi continuamente come il gesto pieno di speranza del pittore di fronte al soggetto di sempre: un gesto ripetuto senza ripetitività. Questo è il letto che mi e vi auguro di rifare oggi, domani e sempre: un’arte di vivere «terra terra», che non significa rasoterra (senza cielo e senza profondità) come ci spingono a fare consumismo, relativismo e individualismo, ma abbracciando, come si può, tutta la terra che ci è data, cielo e sottosuolo compresi. Solo così il «terra terra» ordinario diventa un «Terra! Terra!»: grido gioioso di chi avvista e scopre il nuovo nel consueto. Ma questo può accadere se non rinunciamo a vivere le domande dipinte da Gauguin su sfondo oro: «da dove vengo, chi sono, dove vado?». Domande che, se suonassero vecchie e inutili, offro nella affilata «traduzione» di un ragazzo in una lettera al suo insegnante e mentore: «Ho sentito troppi insegnanti e genitori dire: questi ragazzi non desiderano piu, non si appassionano a niente. La domanda che costoro dovrebbero farsi non e perche noi giovani d’oggi sembriamo non desiderare nulla, ma su cosa sperano loro. Perche poi i ragazzi quella speranza la assimilano come manna dal cielo, come l’aria, anche se sembra che se ne freghino. E i giovani baseranno su questa speranza che hanno respirato la loro identita adulta. Ma la speranza deve essere vera. Smettano, per carita, di tentare di affascinare o tormentare i loro studenti, apprendisti, figli. Vivano la loro speranza e la mostrino al mondo nelle cose che fanno. Siano disposti a vivere per essa. La loro speranza, se è vera, affascina da sola, ma deve essere vera, veramente vissuta». Ecco la sfida educativa: di che speranza viviamo noi?
PS. Ringrazio tutti per la grande passione con cui avete seguito questi «letti»: i vostri consigli, critiche, lettere mi hanno aiutato a riflettere e crescere. Chiedo scusa per gli errori, dovuti ai miei limiti personali e a un’opera viva come l’educazione che, essendo arte e non scienza, non offre manuali e soluzioni certe, ma iniziative personali a partire da principi chiari e situazioni irripetibili: nell’educazione la soluzione sono gli educatori. Un grazie di cuore a Federica, Carlo e mia madre, per il continuo confronto e conforto. Adesso è tempo di tacere, per scoprire nuove terre e quindi nuove parole. Ci rivediamo a settembre.
Fonte: Corriere.it